 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
ALLA MINIERE DI ITTIOLO |
|||||||||||||||||
Il percorso è particolarmente agevole e non presenta particolari difficoltà. Si raggiunge la sp. 25 che porta da Giffoni Valle Piana a Serino dove sulla destra inizia un sentiero che attraversato un ruscelletto con un ponticello raggiunge in pochi metri i ruderi di un opificio industriale che una volta serviva alla estrazione dell’ittiolo, un unguento che si ottiene dagli scisti bituminosi ricchi di depositi fossiliferi ittici e che veniva utilizzato per la sua azione antisettica. La natura fossilifera degli strati della zona era nota fin dai primi dell’ottocento e fu oggetto di diverse attenzioni per un possibile sfruttamento industriale nonché di studi paleontologici da parte dello studioso Costa. Le miniere per la estrazione della preziosa sostanza funzionavano nella prima metà del novecento fin quando la diffusione del mercurio cromo provocò il declino dell’ittiolo. Le testimonianze rimaste di questa attività di estrazione sono oggetto di un piano di recupero da parte del comune di Giffoni Valle Piana. Dall’opificio il sentiero risale sempre in maniera agevole fino al varco del Patanaro ove sulla sinistra scendendo per un ripido sentiero si raggiungono in breve le gallerie principali delle miniere. Al varco del Patanaro ritornando l’associazione in collaborazione con la sede locale del “il Picchio” di Legambiente propone una visita al “Casone”, dove vi è attualmente un museo dedicato agli studi che lo studioso Costa fece degli eccezionali ritrovamenti paleontologici. Egli ebbe il grande merito di far conoscere alla comunità scientifica italiana ed internazionale i nostri magnifici pesci fossili del triassico emersi dagli scisti bituminosi della valle del Cerasuolo. Una terra emersa popolata da una moltitudine di predatori dai denti robusti adatti a triturare i gusci di molluschi bivalvi. Il Costa raccolse e catalogò centinaia di pesci fossili, tra cui anche specie rare, alle quali sono stati attribuiti nomi sfolgoranti come il Paralepidotus ornatus, un semionide molto comune nelle località del Norico, il Sargodon tomicus, i Saurichthys, predatori del triassico che superavano il metro di lunghezza, simili al luccio e pesci volanti del genere thoracopterus e l’Urocomus picentinus descritto dallo stesso Costa. Poi pubblicò a sue spese i risultati delle sistematiche osservazioni geologiche e paleontologiche condotte sul campo in decenni d'intenso studio del territorio del Regno. Due di queste opere, Paleontologia del Regno di Napoli e Fauna del Regno di Napoli rappresentano ancora oggi una delle vette più alte mai raggiunte nel campo degli studi naturalistici in Italia. Ma la vera storia della miniera di ittiolo di Giffoni comincia con Maria Bakunin, (Krasnojarsk 1873- Napoli 1960) la terzogenita figlia del rivoluzionario e filosofo russo Michail Bakunin , che tra il 1910 e il 1920 soggiornò a Giffoni Valle Piana, insieme al professore Francesco Giordano, prestando numerose consulenze all’amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana. Maria Bakunin, Marussia per gli amici, professore emerito di chimica presso l’Università degli studi di Napoli, si dedicò alla definizione della mappa geologica d’Italia, studiando in particolare le rocce metamorfiche impregnate di ittiolo, che caratterizzano anche le montagne dei Picentini appartenenti all’area salernitana. Dopo la visita delle miniere e del museo l’associazione propone un pranzo presso la sede di Legambiente in Curti di Giffoni Valle Piana. |
|||||||||||||||||
SCHEDA TECNICA
|
|
||||||||||||||||
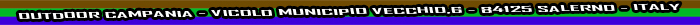 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||




